Amos Zampatti
Governance 2.0
(2018)
L’illuminazione elettrica non è arrivata da un continuo sviluppo delle candele
Oren Harari
Introduzione
Mi pare innegabile che il nostro sistema di governance stia fallendo nell’affrontare le nuove sfide che vengono poste da un pianeta post-globalizzazione, dove vige la libera circolazione di merci e capitali, e quella delle persone si sta prepotentemente ponendo tra i temi più attuali. La misura del fallimento si può constatare da diversi segnali: la crescita incessante del debito pubblico globale (triplicato negli ultimi 10 anni) più rapida anche della crescita del PIL globale, il che dovrebbe farci pensare che quello che stiamo facendo di buono oggi sta avvenendo a spese delle prossime generazioni e non a loro beneficio; un rinnovato nazionalismo che vorrebbe chiudersi in sé stesso di fronte alle sfide globali che si manifesta con l’insorgere sempre più insistente di indipendentismi regionali o con il crescente consenso elettorale di messaggi e personaggi definiti populisti, entrambi figli di una visione semplicistica e identitaria del “noi contro loro”, ingabbiati in una retorica tanto spendibile con le masse quanto pericolosa e storicamente fallimentare, che sanno solo proporre nuovi muri materiali o normativi tra sé e il mondo. Eppure esistono anche buone notizie, come il crescente sviluppo di paesi poveri, che si stanno mettendo in moto proprio grazie all’assottigliamento dei confini economici e dell’isolamento geopolitico precedente alla globalizzazione, più che a certe forme di capitalismo predatorio.
Altro segnale è la crescente astensione democratica: sebbene sia opinione diffusa banalizzare e ridurre il fenomeno a un “chi tace acconsente” o un “non potranno lamentarsi”, non si può negare che le premesse filosofiche che legittimano l’impostazione democratica e che innalzano moralmente questa forma di governo sopra le altre agli occhi delle masse siano irrimediabilmente sbriciolate in una situazione in cui ormai un numero sempre crescente degli aventi diritto al voto rinuncia a votare: a che serve il diritto di voto se votare non conta quasi niente, se il voto si può esprimere solo su questioni del tutto marginali o poco influenti rispetto alle reali decisioni di cosa e come andrebbe fatto?
L'affermazione delle repubbliche democratiche o di forme comunque parlamentari a suffragio universale tra i paesi più avanzati è vissuta dalla grande maggioranza come un fatto acquisito ed inalienabile, il sistema di governo definitivo dopo millenni di brutalità e quindi il più civile di tutti. Eppure nel lungo periodo della storia è una soluzione piuttosto recente e per ora ha garantito solo alcuni periodi di pace in alcuni territori del pianeta al pari di altri sistemi precedenti, ma al tempo stesso ha prodotto le due grandi guerre mondiali causando un numero di gran lunga maggiore di vittime di qualsiasi conflitto precedente, partecipato o in alcuni casi innescato molte guerre con stati meno avanzati, consentito lo sviluppo dei più letali totalitarismi e un gran numero di campi di prigionia tra i quali possiamo collocare anche gli attuali centri per migranti, istituiti nei paesi europei di confine e i ben più atroci in Libia.
Siamo così sicuri che questo paradigma sia il più civile tra quelli possibili, alla luce anche delle innovazioni tecniche, e il più adatto ad affrontare le sfide odierne in una società dalla complessità ed interconnessioni crescenti?
La bufala del contratto sociale
Per trovare delle alternative al sistema che oggi pare l’unico possibile ripartiamo dall’inizio e chiediamoci cos’è la governance e a cosa serve. Senza farne un trattato di filosofia possiamo limitarci a sintetizzarla come l’insieme di istituzioni, diritto e ruoli con cui una società cerca di garantire la pace tra le persone.
Per raggiungere questo obiettivo bisogna innanzitutto ridurre al minimo le occasioni di conflitto, quindi si rende necessario stabilire delle regole del gioco cui attenersi, regole il più possibile condivise da tutti i membri di una data società. Dovrebbe essere evidente che se una regola non è accettata e condivisa, sarà del tutto inefficace nel ridurre i conflitti e la violenza poiché finirebbe sempre con il suscitare ulteriore attrito non solo tra le parti in contrasto ma anche tra i contendenti e la regola stessa, giudicata iniqua da chi la subisce, susciterebbe conflitti anche con l’autore della regola e con l’arbitro che la applica, aumentando a dismisura gli sforzi/i costi per applicarla e, a quel punto, dovrebbe essere imposta con la violenza, minando quindi alle fondamenta l’utilità stessa del sistema di governance (che dovrebbe appunto evitare la violenza e non strumentalizzarla per realizzare il volere di qualcuno).
Storicamente, a torto o ragione, la forma che questa funzione sociale ha assunto è quella della gerarchia di potere: proprio come in natura la legge del più forte, nella società umana i più forti, militarmente, politicamente, elettoralmente a seconda delle epoche e del piano di ragionamento, dettano legge in base alla propria visione, ai propri scopi e alle proprie comodità. Questo sistema non è tuttavia così efficace come si crede acriticamente, proprio perché le regole che vengono scritte in questo modo sono prodotte da qualcuno e imposte a tutti e difficilmente esse risultano poi condivise da chi non ha voce in capitolo nel produrle, discrepanza che trova teorizzazione nel giusnaturalismo, ossia in quella visione giuridica che predica l’esistenza di leggi naturali/divine, più giuste di quelle scritte dai governanti e a cui i governanti stessi dovrebbero attenersi.
Come si concilia quindi questo sentimento contradditorio, che da un lato rivendica la necessità e utilità di un sistema di leggi e dall’altro legittima il primato dei governanti e la sostanziale arbitrarietà con cui scrivono le leggi? Come si giustifica insomma la vittoria del più forte come una conquista di civiltà?
La teoria più accreditata alla base della legittimità dei governanti e del concetto di sovranità come li pratichiamo oggi si fonda sul consenso ipotetico che ognuno offre ad un’autorità superiore in cambio di protezione e un sistema di regole da esso prodotto. Questa astrazione del consenso si è sforzata nei secoli di dimostrare in che modo un patto sociale garantirebbe benefici ai suoi aderenti, del perché sia necessario e in che modo si può presumere un consenso anche se non è esplicito. Insomma una teoria che legittima l’autorità fondandola sulla volontà degli individui e al tempo stesso nega qualsiasi possibilità a chiunque di una volontà diversa da quella metafisicamente ipotizzata.
Tutte queste teorie contrattualistiche presentano delle falle e sono state oggetto di svariate critiche su diversi aspetti (1), a partire dalla mistificazione circa le condizioni iniziali in cui l’umanità sarebbe scesa per sigillare questo patto, partendo da ipotesi smentite dai fatti. Per giungere a questa conclusione così meccanica infatti bisogna dire che l’uomo è homo homini lupus (2), e allora non si spiega perché il governante delegato non dovrebbe comportarsi in modo altrettanto meschino godendo per di più del vantaggio e protezione dato dalla sua posizione, oppure che l'uomo è sempre un essere razionale calcolatore in cerca del massimo profitto materiale come l’homo economicus utilizzato dalla teoria economica e sarebbe quindi possibile predirne la volontà limitandosi a dimostrarne l’utilità razionale (3), in una sorta di delirio scientista.
Un altro aspetto critico è, ad esempio, quello della possibilità di revoca del consenso, che solitamente si risolve dicendo che si è liberi di andarsene, trascurando il fatto che non si è poi così liberi, che anche nella migliore delle situazioni l’onerosità del lasciare la propria casa, famiglia e terra pare decisamente sproporzionata come forma di recesso. Uno dei punti più controversi riguarda poi la natura implicita di tale consenso: applicando gli stessi argomenti con cui si difende la teoria del contratto sociale implicito, si può benissimo giustificare ad esempio la schiavitù (se sei un schiavo gentile e non ti ribelli con violenza o inganno significa che sei d’accordo con la tua schiavitù) oppure l’estorsione da parte della mafia (se abito in un paese controllato dalla mafia e degli scagnozzi armati mi chiedono soldi per tenere aperto il mio negozio sotto la minaccia di chiudermelo o peggio, il semplice pagamento dell’estorsione non significa che sia d’accordo con il sistema mafioso).
Anche identificando il contratto sociale nella sua formulazione esplicita quando questa è rappresentata da una costituzione o un atto fondativo, nessuno ha mai risposto alla questione dell’ereditarietà del contratto (se mio nonno ha fondato un’associazione con degli amici e hanno stipulato un contratto valido tra loro quando io nemmeno ero nato, a che titolo posso essere costretto dagli eredi a farne parte, rispettarne le regole e pagarne i costi senza che nessuno mi abbia chiesto l’adesione?) (4).
Il dato più ridicolo di tutti è infine l’unanimità: tutte le versioni della teoria prevedono che il contratto sia valido universalmente perché unanimemente accettato a un momento zero, senza distinzione alcuna; eppure sappiamo che una simile ipotesi, con una certezza del 100%, non è plausibile nemmeno nella fisica teorica, figuriamoci in fatto di opinioni tra esseri umani. Quindi sarebbe molto più ragionevole considerare che questo tipo di accordo sia stretto solo da una parte, per quanto maggioritaria anche se non dimostrato, ma non certo dalla totalità.
Il vero problema con molte di queste teorie contrattualistiche è che si pongono tutte come giustificazione dello status-quo e non come indagine obiettiva sulla natura del contratto, non hanno alcun interesse nel proporre un progetto sociale ma si limitano ad arrampicarsi sugli specchi pur di non mettere in discussione l’autorità come la conosciamo oggi, ciecamente innamorati dei vantaggi che questa autorità consentirebbe e quindi disposti a ogni sofismo e mistificazione pur di negare la possibilità a qualcuno di svincolarsi o di accusare il più forte di essere solo il più forte e non il legittimo paladino dei deboli.
Non fraintendetemi, quello che vorrei discutere non è tanto l’utilità in sé di associarsi e delegare a qualcuno alcune funzioni come la protezione, ma le condizioni a cui viene concessa questa delega e chi dovrebbe esserne soggetto. Non ho interesse a privare del proprio leviatano chi apprezza questa forma di associazione, ho però la presunzione di definirne dei limiti, come già introdotti da Proudhon nella sua versione della teoria contrattualistica (5), poiché credo che dietro una buona intuizione come quella del contratto sociale si siano prodotte pericolose argomentazioni che possono giustificare qualsiasi intromissione di qualsiasi gruppo in qualsiasi aspetto della vita privata di chiunque, come i regimi totalitari hanno ampiamente dimostrato (infatti le propagande di regime, fascista, nazista o comunista, avevano molto in simpatia questo tipo di teorie per giustificare l’invadenza dello stato). Ovviamente qualsiasi cosa nell’universo produce effetti volontari o meno sul resto dell’universo.
"Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella." affermava Galileo Galilei, quindi dovremmo dedurne che per il bene comune lo stato dovrebbe gestire qualsiasi cosa nell’universo.
Ribadisco che non contesto alcuna legittimità nello stringere un accordo con cui si rinuncia all’uso della forza delegandola ad un solo soggetto in modo che possa produrre difesa contro aggressioni esterne o impiegarla nell'organizzazione sociale come la soluzione di dispute tra consociati o la redistribuzione di risorse nell'interesse dei consociati stessi. Ma andrebbe al tempo stesso precisato che esiste anche una profonda differenza tra questo tipo di accordo, tra consociati e rivolto ad essi soltanto, e un simile accordo da parte solo di alcuni per il dominio su tutti, indiscriminatamente, anche coloro che sono estranei al patto e incolpevoli di aver tentato o minacciato alcuna aggressione ai consociati: mentre la prima si può considerare una legittima associazione, che non viola la libertà di nessuno ma ne è invece frutto, la seconda è solitamente riconosciuta nei tribunali come associazione a delinquere. La differenza è la stessa che corre tra il concetto di legittima difesa e la guerra preventiva: la prima è considerata un innegabile diritto di risposta ad un’aggressione e funzionale all’interruzione dell’aggressione subita, la seconda è solo un’ipocrisia linguistica per definire una forma strategica di aggressione.
La storia, l’antropologia e l’archeologia riportano esempi di forme di dominio, di sovrani e stati fondati sulle conquiste militari o scaturiti dal sangue di qualche rivoluzione e non certo di autorità politiche fondate su ragionevoli premesse approvate all’unanimità dai governati e questo dovrebbe farci sospettare che tali teorie sono inevitabilmente smentite nei fatti e tendono ad apparire più come razionalizzazioni a posteriori o forme di propaganda (6).
Un vero contratto sociale
Cosa possiamo salvare di buono delle teorie contrattualistiche quindi? Sicuramente lo sforzo intellettuale nel dimostrare l’utilità della cooperazione, l’argomentazione in termini altisonanti del concetto “l’unione fa la forza”. Ma forza non significa necessariamente “bene” e nemmeno “ragione” quindi andrebbero semplicemente ridimensionate risparmiandoci i bislacchi voli pindarici e inserendo un solo semplicissimo elemento: la volontà. Reale. Esplicita. Individuale.
Aggiungendo questo concetto basilare scopriamo che l’idea di base del leviatano continua a funzionare, senza forzature e giochi di prestigio filosofici: cosa infatti impedirebbe alle persone di buona volontà di associarsi e vincolarsi per una forma di protezione o per qualsiasi altro vantaggio collettivo unendo gli sforzi? Nulla. Così come nulla impedirebbe loro di difendersi da chi sceglie di non aderire al vincolo se questi volessero attentare alla vita o alla proprietà dei consociati. Se il contratto fosse reale ed individuale inoltre, sarebbe possibile averne più di un tipo, tutti quelli possibili, pur mantenendo il solo requisito del consenso. Ognuno potrebbe benissimo scegliere quale grado di rigore pretendere dai propri associati, si potrebbero fondare comunità molto severe e altre più tolleranti per chi non vuole a sua volta troppa rigidità nei propri confronti. Ogni comunità così formata avrebbe la possibilità di sviluppare le proprie forme di diritto e gli strumenti di governo con cui produrre il proprio diritto, esattamente come succede già oggi nei diversi stati, potremmo avere contratti democratici dove votare rappresentanti o direttamente le leggi così come contratti monarchici che ti risparmiano di interessarti di politica affidandosi ad un “amministratore delegato” ad esempio. Ogni contratto fondato sul consenso, se avesse una concreta possibilità di recesso a certe condizioni, come una durata fissa rinnovabile, o rescindibile in caso di gravi infrazioni da parte di una delle parti, non perderebbe affatto la sua efficacia ma anzi verrebbe a costituirsi una concorrenza di libero mercato tra le diverse formule contrattuali e questo ne garantirebbe la convenienza per i consociati e limiterebbe enormemente la possibilità e la convenienza dell’abuso da parte del leviatano.
Certi contratti potrebbero limitarsi a un semplice accordo di protezione o l’adesione ad un sistema di regole cui i consociati devono attenersi nei rapporti tra loro, altri potrebbero invece prevedere anche pacchetti di servizi collettivi come l’assicurazione sanitaria, l’istruzione, la pensione e ogni altra forma di welfare che i consociati riterranno di voler gestire collettivamente ripartendo costi e benefici nel modo che preferiscono.
L’unico semplicissimo principio a cui dovrebbero attenersi queste comunità contrattuali è quello del consenso, e proprio partendo da questo principio, quello del riconoscere a ciascuno la propria autorità individuale invece di sopraffarla nei fatti con tante parole vuote, si troverebbe il fondamento stesso di un sistema di riconoscimento reciproco tra queste comunità: quello che oggi chiamiamo diritto internazionale. Un protocollo che consenta a queste diverse comunità, soggetti collettivi o come preferiamo chiamarle, di interagire tra loro nel rispetto delle proprie diversità. Alla maggioranza delle persone forse non interessa la libertà se possono vivere in un mondo giusto. Quello che non capiscono però è che per raggiungere ciò che ognuno intende per giustizia (e non vi sarà mai una sola visione per tutti) è necessario che tutti o quanti più possibile abbiano la libertà di produrre quel mondo giusto e altrettanti la possibilità di sceglierlo liberamente, altrimenti l'unica garanzia sarà l'assenza di libertà.
In natura la salute e la stabilità degli ecosistemi è garantita dalla diversità; la molteplicità delle forme di vita che li compongono costituiscono infatti molteplici possibilità di evoluzione e resilienza alle crisi. La diversità rappresenta competizione che tramite i meccanismi evolutivi consente la selezione e il successo “meritocratico” del più adatto. Non dobbiamo combattere la diversità, non dobbiamo considerarla uno sgradevole difetto da correggere ma, al contrario, possiamo renderla la nostra migliore risorsa.
Per volontà e non per nascita
A questo punto sorge naturale un quesito: come potrebbero tutti i residenti di un medesimo territorio trovare una forma di consenso e generare un proprio stato volontario unitario per gestire quel territorio, senza ricadere nell’errore di schiacciare gli individui che non vogliono aderirvi?
Come già accennato, il punto forse più critico su cui falliscono le teorie tradizionali del contratto sociale è riconducibile all’universalità degli esseri umani: l’unanimità del consenso. Questo aspetto consente di evitare il problema della proprietà/diritto di abitazione di un territorio: se il patto è riconducibile all’unanimità intera allora tutto il territorio è competenza del leviatano, anche se possiedi un regolare titolo di acquisto o successione; pertanto l’unico modo di svincolarsi dal contratto è lasciare quel territorio. Ma qui incontriamo il secondo problema nascosto sotto il tappeto: se il contratto sociale ha dato vita all’autorità politica tramite l’unanimità dell’umanità intera, tutta la terra abitata è di proprietà dei consociati e se si vuole uscire dal patto dove si può andare? Se tutti i territori abitabili sono finiti sotto la giurisdizione insindacabile di un leviatano come si fa ad esprimere la volontà di recidere questo patto implicito, viaggi spaziali esclusi? Viceversa, se il contratto non è universale ma territoriale, non sarebbe possibile non aderire o recedere ma solo trasferirsi in un territorio sotto il controllo di un altro leviatano, di cui oltretutto non siamo nemmeno parte, finendo dalla padella alla brace e perdendo anche quell’unica finzione di potere “del popolo” esercitata tramite il diritto di voto e le tutele riservate alla cittadinanza tanto cara ai grossolani sostenitori della democrazia.
Innanzitutto lo stato, come conosciuto oggi, si fonda su un monopolio territoriale, l’idea che all’interno di un perimetro tutto sia riconducibile al governo di qualcuno, re, oligarchi, parlamento o dittatore che sia, un po’ come fanno in natura certi maschi dominanti che marcano il territorio e usano violenza contro qualsiasi insubordinazione interna o minaccia esterna. La storia dimostra abbastanza bene come questa frammentazione del pianeta in confini sia stata motore di molte violenze mentre non saprei elencarne nemmeno un vantaggio, se non per qualcuno a scapito di qualcun altro. Le motivazioni di questo aspetto territoriale sono da ricondursi, secondo l’antropologia, ad un’origine sociale (7): si è evoluto da quello tribale/familiare, in cui tutti i membri di una società risiedevano in un medesimo luogo ed erano imparentati tra loro, fondando sostanzialmente il presupposto che i territori coincidano con le popolazioni e che all’interno di diverse aree geografiche sia possibile distinguere gruppi di persone omogenei, che condividono quindi una medesima cultura, che è poi il collante alla base del sistema di governance (è più facile sviluppare regole condivise tra persone simili). In questo senso è stato sancito anche il principio di autodeterminazione dei popoli stabilendo di fatto la legittimità di un gruppo sociale di rivendicare una propria autonomia di gestione (8). Anche in passato comunque, quando il criterio di organizzazione sociale si è ritrasferito dal territorio alla parentela/identità culturale dopo il crollo dell’impero romano d’occidente, si è trovata una soluzione piuttosto semplice per capire come comportarsi con elementi estranei al proprio gruppo sociale: il diritto personale, e cioè l’idea che una persona fosse vincolata alle proprie tradizioni e che fosse giudicata in base a quelle, a prescindere da dove si trovasse. Per avere un esempio basti pensare al medioevo che viveva una profonda pluralità di ordinamenti giuridici coesistenti nelle medesime città (9), o alla lex mercatoria.
Anche oggi esistono situazioni di convivenza sul medesimo territorio di cittadini soggetti a diversi ordinamenti giuridici come i corpi diplomatici. Recente è la ricollocazione di una grande agenzia dell'Unione Europea per la quale erano in competizione diverse città: la possibilità di avere un simile ufficio sul proprio territorio significa infatti ospitare centinaia di funzionari soggetti a leggi straniere e non locali tra cui anche certi vantaggi fiscali, eppure nessuno ha sospettato nemmeno per un momento che una tale commistione di ordinamenti provocasse caos, al contrario è stata auspicata e contesa.
Se dunque possiamo immaginare un reale “contratto sociale”, o meglio un contratto politico commutativo limitato ad alcune questioni sociali come lo definiva Proudhon, che senso avrebbe applicarlo in base a un fattore del tutto casuale e “non-meritocratico” come il territorio di nascita e non invece alla volontà e identità del singolo individuo?
Verso un nuovo ordine
Fino ad oggi si è tentato in ogni modo di limitare il potere, per lo più tramite la finzione della separazione dei poteri ideata da Montesquieu: basta allargare lo sguardo sopra i confini nazionali per accorgersi che tutta la separazione avviene solo tra la mano destra e la mano sinistra di un unico soggetto giuridico detto Stato, che reincarna la millenaria casta dominante di privilegiati a scapito del resto della popolazione, e che questo non limita affatto il potere dello stesso ma si moltiplica sotto diverse forme in competizione tra loro per una fetta più grande di risorse e competenze, a scapito dei governati.
E se fosse possibile limitare il potere distribuendolo invece che concentrandolo in un unico ente?
Un recente studio di Yaneer Bar-Yam (10) circa la complessità crescente della società, suggerisce come l’unica possibilità per aumentare le nostre capacità di affrontare le sfide che ne derivano in termini di governance risieda proprio nel superamento del paradigma gerarchico (di cui le moderne democrazie sono ancora intrise) per abbracciare nuovi modelli distribuiti, in cui diverse funzioni sono assunte da diverse istituzioni o gruppi specializzati, connessi direttamente tra loro in una rete di relazioni piuttosto che raccolti sotto un'unica guida dall’alto.
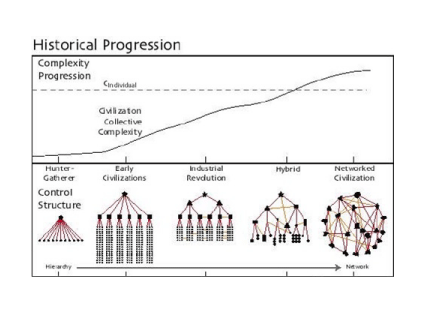
Numerosi testi sono stati prodotti circa esempi di gestione in passato e la futura possibilità di riorganizzazione in chiave decentralizzata di diverse funzioni che sono oggi esclusiva monopolistica degli stati, dalla produzione di leggi alla gestione dei tribunali, dalla sicurezza (11) alla moneta, come possiamo constatare oggi con le criptovalute basate su tecnologia blockchain. Forse è arrivato il momento di considerare seriamente queste alternative e comporne un quadro di insieme, una reale alternativa, fondata davvero sulla civiltà e non sulla forza, basata sul consenso individuale e sulla libera concorrenza di sistemi giuridici e sociali in competizione tra loro, un cambiamento a spese dei potenti di turno dello status quo.
Per comprendere come sia possibile ad esempio avere uno stato volontario/contrattuale e contemporaneamente gestire un territorio è necessario separare due funzioni: quella di governo del territorio (strade, rifiuti, ambiente, servizi locali), che non può esistere se non a scala locale da una qualche istituzione a cui partecipano i residenti di quel territorio (che in questo caso esprimerebbero sì la propria adesione con la propria presenza o libertà di spostamento), e quella di governo sociale degli appartenenti a quella comunità (alla quale aderirebbero per contratto), senza alcun rapporto di subordinazione tra le due “gestioni”. Questo comporterebbe una sostanziale ridefinizione delle competenze dello stato, rompendo di fatto il monopolio assolutista e totalitario che lo caratterizza oggi all’interno dei propri confini, garantendogli di fatto una completa arbitrarietà e impunità che difficilmente sono messe in crisi anche dalle istituzioni internazionali nei casi più eclatanti, soprattutto quando non sussiste alcun interesse predatorio da parte degli stati più forti nell’aiutare in qualche modo popolazioni “altrui”.
Una simile differenziazione e commistione di cittadinanze e residenze sarebbe inoltre un’ottima garanzia contro l’eventualità di conflitti tra stati sociali, poiché renderebbe particolarmente difficile dichiarare guerra a qualcun altro se i propri cittadini e quelli del nemico vivessero mescolati ovunque nel mondo (12). Nelle medesime città vivrebbero inoltre altri cittadini di ulteriori nazionalità che avrebbero probabilmente tutto l’interesse a mantenere la pace locale. Interi sistemi di armamenti infine, tra i più letali come le armi nucleari, risulterebbero improvvisamente inutilizzabili e del tutto inutili, prospettiva che ad oggi nessun accordo sul disarmo è stata in grado nemmeno di paventare.
Possiamo quindi passare da un paradigma centralista e autoritario, fondato sulla gerarchia e sulla costrizione e caratterizzato dall’irresponsabilità del potere, a uno decentralizzato, a intelligenza e responsabilità diffusa, basato sulla libera adesione. Possiamo rompere quei grumi monopolistici che sono gli stati odierni, ognuno onnipotente in quel piccolo ritaglio di pianeta che è casa propria, e riappropriarci come umanità di tutte quelle funzioni necessarie, svilupparle in tante istituzioni e comunità quante ne saranno richieste, garantite universalmente a chiunque desideri parteciparvi a prescindere dal territorio di nascita. Possiamo sostituire la collaborazione alla legge del più forte. Potremmo anche riscoprire la vera natura dell’uomo come animale sociale: l’individuo non è l’anello di una catena di comando o un gradino di una piramide, è il luogo di tutte le relazioni, l’unico possibile.
Riferimenti
(1) Mike Huemer, The problem of political authority, 2013
(2) Thomas Hobbes, Il Leviatano, 1651
(3) John Rawls, A Theory of Justice, 1971
(4) Lysander Spooner, No Treason, 1867
(5) Pierre-Joseph Proudhon, Del principio federativo, 1863
(6) James C. Scott, Against the grain, 2017
(7) Harold B. Barclay, Lo Stato, 2003
(8) Corte Suprema del Canada, Sentenza 385/1996
(9) Paolo Grossi, L’ordine giuridico medioevale, 1995
(10) Yaneer Bar-Yam, Complexity rising: from human beings to human civilization, a complexity profile, Encyclopedia of Life Support Systems, 2002
(11) Gustave de Molinari, Sulla produzione della sicurezza, 1849
(12) John Gall, Sistemantica, 1975